Il controverso primo presidente della Romania post-comunista Ion Iliescu è morto oggi, 5 agosto 2025, all’età di 95 anni. Era ricoverato in ospedale a Bucarest da inizio giugno per un tumore polmonare, e da tempo le sue condizioni erano considerate molto critiche.
L’ex presidente è stata una delle figure più influenti e, insieme, controverse della storia recente del paese, plasmandolo negli anni cruciali mentre usciva dal comunismo e diventava lentamente una democrazia. Iliescu è stato presidente della Romania per undici anni, dal 1990 al 1996, ed è stato nuovamente eletto nel 2000, fino al 2004.
La vicinanza con il Partito Comunista
Nato nel 1930 a Oltenița, nel județ di Călărași, proveniva da una famiglia di attivisti comunisti. Lui stesso entrò giovanissimo nelle file del partito, divenendone presto una figura di rilievo. Nei primi anni Cinquanta studiò a Mosca presso l’Istituto di ingegneria elettrica, dove fu il leader degli studenti romeni in URSS e conobbe sua moglie Nina. Di quel soggiorno sono rimasti a lungo dei dubbi circa un suo possibile reclutamento come spia per il KGB, la polizia segreta sovietica, mai però dimostrati.
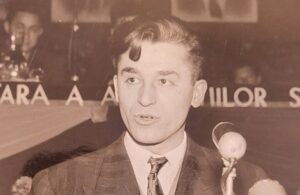
Rientrato nel 1954 in Romania, entrò subito nella dirigenza dei Giovani Comunisti, di cui divenne segretario due anni più tardi. Con l’arrivo di Nicolae Ceaușescu al potere alla morte di Gheorghe Gheorghiu-Dej nel 1965, scalò rapidamente le gerarchie del partito, fino a diventare Ministro della Gioventù nel 1967. Inizialmente fu molto vicino al dittatore, anche perché lo conosceva fin dall’infanzia, grazie all’amicizia fra la matrigna e Elena Ceaușescu. Tuttavia nel tempo venne allontanato e passò sempre più in secondo piano, pur rimanendo una figura nota della nomenklatura. Negli anni Ottanta fu considerato da alcuni come il possibile successore riformista di Ceaușescu, anche se dai documenti d’archivio non è mai emersa alcuna prova di una sua reale opposizione né di iniziative o volontà concrete di riforma del sistema comunista – cosa, d’altronde, quantomai difficile nel tipo di regime che era la Romania.
Effettivamente non si sa molto della sua biografia, e il suo passato precedente al 1989, compresi i suoi anni da comunista, rimangono largamente un mistero. I documenti ufficiali sono scomparsi dagli archivi, e le uniche due pagine ritrovate sono state scambiate con quelle di un’altra persona. Lui stesso ha sempre parlato poco di sé, fra numerosi cambi di versione e altrettante contraddizioni.
Il ruolo nella Rivoluzione del 1989 e i primi anni post-comunisti
Durante la rivoluzione che rovesciò Ceaușescu e mise fine al regime comunista, Iliescu si presentò come dissidente e riuscì a imporsi come leader delle proteste di dicembre e della transizione post-comunista, diventando presidente ad interim e poi venendo eletto primo presidente della Romania postdecembrista nelle prime elezioni libere del maggio 1990. Tuttavia, proprio il suo ruolo durante e dopo la rivoluzione resta estremamente complesso e controverso: specialmente nei primissimi tempi, non è chiaro quanto volesse realmente abolire il comunismo e attuare una transizione democratica, o piuttosto semplicemente assumere il comando della nuova leadership.
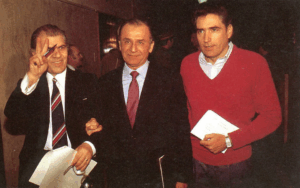
Il suo giudizio oggi è indissolubilmente legato alla transizione post-comunista della Romania. La presidenza di Iliescu è stata definita dal suo sforzo di gestire il fragile riemergere della Romania dalla dittatura di Ceaușescu. In quegli anni, ha sostenuto un percorso cauto di riforme graduali, opponendosi ai modelli di “terapia d’urto” economica adottati da altri stati dell’ex blocco orientale, come ad esempio la Polonia. Piegata dal decennio di durissime restrizioni imposto da Ceaușescu negli anni Ottanta per ripagare il debito pubblico, la Romania dei primissimi anni Novanta si trovava con un sistema paese a pezzi per il crollo delle strutture comuniste, un’inflazione galoppante, disoccupazione diffusa e infrastrutture vetuste. Di fronte a questo scenario, Iliescu preferì, a torto o a ragione, mantenere una certa continuità e stabilità per garantire la coesione sociale, evitando cambiamenti drastici e troppo rapidi che avrebbero potuto strappare il tessuto sociale, già ferito da tensioni economiche, sociali, politiche ed etniche. I suoi ammiratori gli attribuiscono il merito di aver garantito stabilità in un periodo che avrebbe potuto fra precipitare il paese nel caos, preservando l’unità nazionale e imponendo gradualmente le trasformazioni democratiche ed economiche necessarie, evitando gli sviluppi tragici che si videro nella ex Jugoslavia e in Unione Sovietica. Tuttavia, il suo approccio fin troppo prudente ha attirato anche molte critiche: i governi occidentali e i partiti liberali lo accusavano di voler mantenere lo status quo comunista, criticando il ritmo troppo lento che aveva dettato per attuare le riforme e la decisione di lasciare ex membri del regime in posizioni di potere. I detrattori sostenevano poi che avesse rallentato lo slancio democratico della Romania, consentendo alla corruzione di proliferare e perdendo occasioni chiave per modernizzare il paese.
In effetti, nei primi anni Novanta la Romania sotto la sua presidenza visse violenze, scontri, repressioni e conflitti interetnici, come quelli fra romeni e ungheresi a Târgu Mureș nel 1990, in cui persero la vita fra le cinque e le otto persone. Anche l’apertura democratica fu spesso gestita con una certa resistenza e un certo grado di arbitrarietà. In quegli anni, infatti, il Partito Socialdemocratico da lui fondato governò con partiti apertamente nostalgici del comunismo, estremisti e antioccidentali, mentre ex uomini della Securitate, la polizia segreta romena, e del fu Partito Comunista continuarono a ricoprire ruoli rilevanti nelle istituzioni. La Romania si trovò ben presto indietro nella democratizzazione e nell’implementazione delle riforme volte a trasformare l’economia in un sistema di mercato funzionante. Anche sul piano internazionale la Romania apparve in ritardo: in un momento di sempre maggiori contatti e graduale avvicinamento con l’Occidente, il paese mantenne per diversi anni posizioni ambigue con la Russia, esemplificate dalla firma di un trattato di amicizia nel 1991, quando l’Unione Sovietica stava già morendo. Per questa sua ambivalenza geopolitica, secondo un file desecretato dall’FBI, fino al 1994 gli Stati Uniti considerarono la Romania un paese ostile, insieme a Cuba, Iraq e Libia.
Dal 2000 al 2004, durante il suo terzo mandato Iliescu ha, però, aggiustato la rotta: ha raggiunto un accordo con la famiglia reale e ha permesso a Re Mihai di stabilirsi nuovamente in Romania, dopo che negli anni Novanta ne aveva impedito il ritorno e criticato duramente la figura. Sono migliorati significativamente anche i rapporti con l’Europa e, soprattutto, con Washington, grazie anche al ruolo nuovo e di primo piano giocato dalla Romania dopo l’11 settembre nella lotta contro il terrorismo avviata dagli Stati Uniti in Medioriente. Questo ha portato Iliescu a poter firmare l’adesione del paese alla NATO, avvenuta poi ufficialmente nel 2004, dopo che Bucarest era stata esclusa dal primo allargamento nel 1999.

Ma ecco, di nuovo, delle ombre: nel 2006, quando il nuovo presidente che gli succedette, Traian Băsescu condannò definitivamente il comunismo con una storica dichiarazione alle Camere riunite, Iliescu si oppose fermamente e si rifiutò di presentarsi in parlamento. Dichiarò anzi che l’atto era una “montatura politica, unilaterale, partigiana e primitiva. Non accetto di essere presentato come un pilastro del comunismo”.
Le controversie
Fra le molte ombre, anche quelle legate al suo ruolo e a quello del Fronte di Salvezza Nazionale negli eventi di dicembre che hanno portato all’esecuzione di Nicolae Ceaușescu e alla caduta del regime, ma anche alle Mineriade del 1990. Durante la più grave, quella di giugno, il governo chiese l’intervento dei minatori dalla Valle del Jiu per reprimere nel sangue le proteste in piazza Università, per la maggior parte partecipate da studenti che denunciavano la continuità della “nuova” classe politica post-decembrista con quella del periodo comunista. 10mila minatori arrivarono nella capitale; durante i violenti scontri, sei persone morirono e circa un migliaio furono ferite. Per il loro intervento, Iliescu spese parole di ringraziamento, dichiarando che si trattava di un gesto dovuto in riconoscimento alla “solidarietà e spirito civico” che avevano dimostrato.
Per entrambi gli episodi, Iliescu è stato messo sotto processo in anni recenti con accuse di crimini contro l’umanità, legate alle vittime delle violenze di quei momenti. Il primo processo, avviato nel 2018, è però stato più volte bloccato, passando da un’autorità giudiziaria all’altra e, di fatto, mai conclusosi a causa delle lungaggini burocratiche. Per le Mineriade, invece, il processo è terminato senza condanna.
Cosa rimarrà di Ion Iliescu?
Fra le sue eredità politiche, il PSD, il Partito Socialdemocratico, da lui fondato nei primi anni Novanta, trasformatosi sotto molti nomi, e che tuttora gioca un ruolo chiave nella politica rumena. A partire dalla metà degli anni Duemila, Iliescu si ritirò gradualmente dalla vita politica attiva, al termine del suo ultimo mandato da presidente e dopo aver perso la leadership del suo stesso partito. Aveva però aperto un blog nel 2011 attraverso il quale continuava a parlare al pubblico.
Con la morte di Iliescu si chiude un’epoca complessa e controversa, fatta di contraddizioni e compromessi. È stato un personaggio caratterizzato da molte luci e molte ombre, amato e odiato, criticato e lodato, demonizzato e santificato. Gli anni a venire permetteranno di comprendere meglio la sua figura, chiarendo le sue scelte, con i suoi errori e pregi, e sarà possibile osservare la sua eredità e storia con maggiore lucidità e profondità.
Foto: Hotnews
 East Journal Quotidiano di politica internazionale
East Journal Quotidiano di politica internazionale




