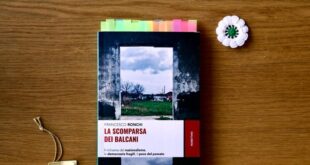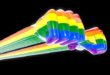Dal marzo del 2022, la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia è stata occupata dalle forze russe. …
Leggi tuttoMACEDONIA DEL NORD: Verso le elezioni presidenziali, previsto testa a testa
Macedonia del Nord al voto per eleggere un nuovo presidente: previsto testa a testa tra il president…
IRAN: Comprendere il conflitto con Israele (1)
Ripercorriamo le relazioni bilaterali tra Iran e Israele dagli anni '70 in poi, necessarie per compr…
La comunità Arbëreshë, gli albanesi d’Italia
Gli Arbëreshë, ovvero gli Albanesi d'Italia, vivono in Italia da quasi sei secoli e sono custodi del…
CROAZIA: L’HDZ di Plenković vince le elezioni, ma per governare servono alleati
Il premier uscente Andrej Plenković batte la coalizione di centro-sinistra guidata da Zoran Milanovi…
CROAZIA: Paese al voto, sfida tra il premier Plenković e il presidente Milanović
Croazia al voto: è sfida tra il premier uscente Andrej Plenković, e il capo dello stato Zoran Milano…
TURCHIA: Tutte le donne (sindaco) contro il presidente
Cosa resta del rinnovato scenario politico del Paese? Una prevalenza di donne sindaco come non era m…
ALBANIA: L’accordo con l’Italia sui migranti, come governare il territorio esternalizzando le frontiere
La polemica che ha scosso il parlamento albanese a novembre 2023 in seguito all’accordo…
KOSOVO: Vicina l’adesione al Consiglio d’Europa, ma restano i nodi con la Serbia
Il Kosovo è vicino all'adesione al Consiglio d’Europa. Un passaggio storico, ma sono ancora molti i …
SERBIA: Minacce al prof. Dinko Gruhonjić, l’Università sotto attacco dei nazionalisti
A Novi Sad, esponenti di estrema destra occupano la facoltà di Filosofia per chiedere il licenziamen…
UCRAINA: droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia
Dal marzo del 2022, la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia è stata occupata dalle forze russe. Nonosta…
-
UCRAINA: droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia
-
Nemici necessari, gli emigranti tagichi in Russia
-
RUSSIA: Cosa sta succedendo a Belgorod?
-
Dall’Ucraina: realtà del fronte e resilienza della nazione
-
RUSSIA: Le elezioni più noiose dell’anno?
-
Putin non è fascista. Un libro di Andrea Borelli per capire il putinismo
-
SLOVACCHIA: Pellegrini vince le elezioni presidenziali
Con il 53,12% delle preferenze, Peter Pellegrini diventa il nuovo Presidente della Slovacchia. Pesano il voto dell'estrema destra e della minoranza ungherese.
Leggi tutto -
UNGHERIA: L’uomo che fa vacillare Orbán
-
SLOVACCHIA: Alle presidenziali i liberali in vantaggio, ma si va al secondo turno
-
UNGHERIA: Due dimissioni pesanti preludono a grandi cambiamenti?
-
MACEDONIA DEL NORD: Verso le elezioni presidenziali, previsto testa a testa
Macedonia del Nord al voto per eleggere un nuovo presidente: previsto testa a testa tra il presidente uscente, socialdemocratico, e la candidata di centro-destra, in attesa delle elezioni parlamentari di maggio
Leggi tutto -
La comunità Arbëreshë, gli albanesi d’Italia
-
CROAZIA: L’HDZ di Plenković vince le elezioni, ma per governare servono alleati
-
CROAZIA: Paese al voto, sfida tra il premier Plenković e il presidente Milanović
-
ROMANIA: Sempre fedele alla NATO. Sorgerà sul mar Nero la più grande base d’Europa
Nei prossimi anni la Romania ospiterà la più grande base NATO d'Europa, ennesima conferma del rapporto "speciale" tra Bucarest e Bruxelles
Leggi tutto -
ROMANIA: Il Mărțișor, molto più di un fiocco rosso e bianco
-
TRANSNISTRIA: Nessuna annessione alla Russia
-
IRAN: Comprendere il conflitto con Israele (1)
Ripercorriamo le relazioni bilaterali tra Iran e Israele dagli anni '70 in poi, necessarie per comprendere al meglio gli avvenimenti di oggi.
Leggi tutto -
TURCHIA: Tutte le donne (sindaco) contro il presidente
-
Turchia: L’Eid al-fitr più dolce per il sindaco di Istanbul
-
Putin non è fascista. Un libro di Andrea Borelli per capire il putinismo
Secondo molti osservatori, Putin sarebbe il volto del fascismo moderno. Un bel libro di Andre Borelli ci mostra invece quanto il putinismo sia debitore allo stalinismo, aiutandoci a comprendere meglio l'ideologia del Cremlino...
Leggi tutto -
Il sionismo nasce in Serbia? Judah Alkalai, maestro di Herzl
-
IRAN: il cammino delle comunità giudeo-persiane (4)
-
Dove si spengono gli imperi: gli ultimi ottomani di Agadez
-
Dove si spengono gli imperi: il principato di Teodoro in Crimea
-
GRECIA: De Chirico e i treni della Tessaglia
-
Dal radicalismo al terrorismo: l’Islam nel contesto dell’Asia centrale
Nel contesto dell’Asia centrale l’Islam religioso è un fenomeno relativamente recente se rapportato alla secolarità …
Leggi tutto -
IRAN: Spira un vento di cambiamento
-
Le donne vittime del Caucaso: Seda Sulejmanova
Sono più di 150 giorni che non si hanno notizie di Seda Sulejmanova, la ragazza cecena che nel 2022 era scappata dalla sua famiglia.
Leggi tutto -
Un cambiamento geopolitico nel sud del Caucaso
-
CINEMA: “Landshaft”, psicogeografia del confine armeno-azero
-
LITUANIA: La vita di Lionel, da minaccia ibrida a padre di famiglia
Lionel è arrivato in Lituania nel luglio 2021, con la più grande ondata di migranti irregolari provenienti dalla Bielorussia. Da due anni e mezzo, combatte la sua battaglia per costruire una vita in Lituania per sé e la sua famiglia.
Leggi tutto -
Lituania e Russia: possibili scenari di conflitto?
-
La sconfitta di Alternative für Deutschland in Turingia e le proteste di piazza in Germania
In seguito a proteste di massa nazionali, Alternative für Deutschland ha subito una sconfitta inaspettata nelle elezioni regionali in Turingia. La palma del vincitore é andata a Christian Herrgott della CDU, che ora diviene così il nuovo governatore del Landkreis locale dopo le votazioni nel distretto di Saale-Orla.
Leggi tutto -
RUSSIA: Verso la chiusura del confine finlandese
-
TURCHIA: Le campionesse di volley e un Paese diviso
La nazionale femminile di pallavolo della Turchia ha vinto l'europeo. Guidate dal talento di Melissa Vargas, le ragazze di Santarelli hanno fatto parlare di sé dentro e fuori dal campo. Gli attacchi omofobi a Karakurt hanno però restituito l'immagine di un Paese diviso...
Leggi tutto
-
La scomparsa dei Balcani. Una regione “dimenticata” nel libro di Francesco Ronchi
TITOLO: La scomparsa dei Balcani. Il richiamo del nazionalismo, le democrazie fragili, il peso del …
Leggi tutto
 East Journal Quotidiano di politica internazionale
East Journal Quotidiano di politica internazionale